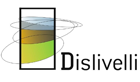"... avevo scoperto l'abisso della rassegnazione, la virtù del distacco, il piacere del pensare pulito, l'ebbrezza della creazione politica, il fremito dell'apparire delle cose impossibili..." Altiero Spinelli
Le domande che la politica non si pone
.jpg)
«La maledizione di vivere tempi interessanti» (73)
di Michele Nardelli
Quando a gennaio di quest'anno proposi un viaggio attraverso la crisi della politica, l'intento era quello di indagarne categorie e paradigmi in un percorso che sarebbe durato almeno un paio d'anni, al riparo dall'agenda politica e dalle sue scadenze.
Sapevo che non sarebbe stato facile riuscire in qualche modo ad astrarsi da quello di cui tutti parlano, ma ero altrettanto consapevole che i tempi della ricerca e dell'elaborazione non ammettono scorciatoie e che in questo contesto provare ad incidere sull'attualità politica sarebbe stato fuorviante e probabilmente inconcludente. Perché i processi degenerativi della politica sono tali che le domande di fondo nemmeno si pongono. Perché tali processi non riguardano solo i partiti ma l'insieme dei corpi intermedi e della società, come a dire che fra il paese legale e quello reale non vi è in fondo molta differenza. E infine perché il campo dell'offerta politica – almeno per chi ne ha un'idea collettiva – sembra oggi in larga misura impraticabile.
Non mi stupisco pertanto dell'increscioso spettacolo che il confronto politico sta dando di sé, tanto nella sua incapacità di raccontare il presente come nel cavalcare gli istinti peggiori, a cominciare da quel “prima noi” – non mi stanco di dirlo – in fondo non molto diverso da quel “Deutschland über alles” che ha disseminato il Novecento di morte e distruzione.
Come non mi stupisco dell'incapacità da parte degli eredi delle migliori tradizioni politiche di cercare e trovare nuove sintesi culturali, ciascuno intento ad indicare le responsabilità di una sconfitta annunciata cui il centrosinistra sta andando incontro, senza comprendere che essa non è solo il risultato della frammentazione bensì di una strada che ci ha portati sull'orlo di un baratro senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Tanto è vero che il tema della crescita, nonostante la conclamata insostenibilità del modello di sviluppo imperante, è ancora (e trasversalmente) al centro dei programmi dei partiti.
I quali si differenziano fra il continuare ad immaginare che le risorse siano infinite – a prescindere dalla loro iniqua distribuzione (data dagli uni come esito naturale e immodificabile del mercato e da altri come una buona ragione per definirsi ancora comunisti) – e la fine dell'umanesimo, ovvero che sia lecito dividere l'umanità fra inclusi ed esclusi, immaginando che tre o quattro miliardi di persone possano essere considerate “in esubero”.
Visioni diverse che hanno però alcuni punti di contatto. Così che ad invocare la “non negoziabilità” dei propri stili di vita sono stati venticinque anni fa Tony Blair e George Bush, esponenti di rappresentazioni politiche opposte.
L'esito di questa trasversalità è la guerra mondiale nella quale siamo immersi e contro la quale si è alzata la voce di Papa Francesco. Una guerra dichiarata ogni giorno nel momento in cui si afferma “american first” o “prima gli italiani” o, ancora, “non nel mio giardino”.
Per uscirne dovremmo resettare le vecchie categorie analitiche ed immaginare nuovi paradigmi e, a partire da questi, una nuova progettualità politica. Il che è oggettivamente difficile perché cambiare quelli che abbiamo sin qui coltivato significa tornare sui propri passi e riconoscere dove si è sbagliato, ma anche cominciare a dire cose che gran parte delle persone non vogliono sentire.
Come, ad esempio, che viviamo al di sopra delle nostre possibilità e che dovremo riconsiderare (e riqualificare) i nostri consumi quando sino a ieri si è sostenuta la necessità di un loro rilancio. Che “sicurezza” vuol dire letteralmente “prendersi cura” non rinchiudersi, costruire muri o armarsi. Che in un mondo interdipendente non c'è nulla che non ci chiami in causa e che se intorno a noi c'è sofferenza, questa prima o poi entrerà nelle nostre vite. Che dovremmo smetterla di ragionare in termini di stato-nazione quando tutto è ormai sovranazionale e territoriale, riscoprendo il valore del federalismo solidale come assunzione di responsabilità verso la “Terra-patria”. Che l'Europa politica dovrebbe essere una prima risposta in grado di regolare il lavoro, il rapporto con l'ambiente, le scelte energetiche, le reti commerciali nelle mani degli oligopoli, il welfare, la difesa comune (tagliando drasticamente i 260 miliardi di euro che i paesi dell'Unione spendono ogni anno per i propri eserciti), la cittadinanza. Ma anche capace di reimmaginare al suo interno le geografie politiche e istituzionali oltre le nazioni. Che i cambiamenti climatici non conoscono confini e che se non cambiamo modello di sviluppo si trasformeranno in altrettante emergenze, ambientali e sociali. Che molti dei paesi che chiamiamo poveri non lo sarebbero affatto se non li avessimo resi tali. E, per dirla tutta, che molto spesso dietro la logica degli aiuti umanitari si celano forme di neocolonialismo con buona pace per le anime belle che si commuovono di fronte ai bambini con le pance gonfie e le mosche sugli occhi esibiti dall'industria dell'umanitario e che pensano di poter lavarsi la coscienza con qualche euro che inviano con un sms da quegli stessi smartphone realizzati contro ogni rispetto dei diritti umani. E, ancora, che sbandierare una ripresa che si alimenta di precarietà, produzioni belliche, territori cementificati al solo scopo di produrre rendita finanziaria, servizi di logistica che rendono invivibili (e inguardabili) le nostre periferie, innevamento artificiale quando i nostri ghiacciai scompaiono e non abbiamo nemmeno l'acqua per coltivare i campi, è da irresponsabili. Che abbandonare la montagna o le aree rurali per vivere in città sempre più grandi nelle quali si è sempre più soli fa parte dell'insostenibilità di modelli che riducono a mercato ogni bisogno, comprese le dimensioni relazionali. Che gran parte della povertà con cui abbiamo a che fare, qui come altrove, è prima di tutto un fatto culturale e di modelli di consumo che condizionano quotidianamente i nostri comportamenti. E che – lasciatemelo dire – è ipocrita invocare la cultura della legalità di fronte a leggi che affermano il reato di clandestinità o al moderno olocausto che si consuma nel Mediterraneo.
Per ciascuno di questi ed altri aspetti non servono aggiustamenti. Occorre un radicale cambio di prospettiva che metta al centro il tema del limite, a partire dal quale delineare un nuovo umanesimo dopo quello narciso e povero di mondo che abbiamo sin qui conosciuto.
E malgrado sia del tutto evidente che riproporre gli schemi del passato non ci aiuta a dare una risposta né alla crisi dell'Europa e degli stati nazionali, né all'insostenibilità del nostro presente, né tanto meno alla crisi delle forme della democrazia e della rappresentanza, nel confronto sulla questione delle alleanze e dei programmi in vista delle elezioni politiche della prossima primavera, della necessità di un cambiamento profondo di sguardo sul presente non c'è traccia.
Ma come si può pensare che la questione del lavoro possa essere affrontata in termini di articolo 18 o di jobs act, quando siamo in presenza di masse enormi di persone disposte a lavorare in condizione di schiavitù? O di qualche mese di età pensionabile quando il concetto stesso di pensione è in buona sostanza cancellato per chi ha meno di quarant'anni se non in termini di assicurazione privata? O forse non sappiamo che la sanità pubblica (e con essa gran parte del welfare) è ormai appannaggio di un gruppo esiguo di paesi nei quali peraltro si sta rapidamente smantellando e che – come è accaduto negli Stati Uniti – sono le masse diseredate a votare per il candidato che voleva abrogare l'“Obama-care” in nome del “dateci il denaro che ci arrangiamo”?
Lo abbiamo capito o no che si è esaurito un tempo del quale siamo ancora prigionieri e che un tempo nuovo richiederebbe – se vogliamo evitare la guerra di tutti contro tutti – di rivedere in profondità quel che fin qui abbiamo chiamato progresso? Il fatto è che della cultura del limite non ne vogliamo sapere. Nuovo paradigma, ma antica questione.
Analogamente, non mi appassionano gli appelli all'unità per evitare che a vincere siano la destra o i 5 Stelle, perché se non si parte dal cambio dei paradigmi si può perdere anche vincendo; come non mi convince il prendere corpo di aggregazioni elettorali che in questo vuoto di pensiero nascono già vecchie e, a guardar bene, più funzionali a dare rappresentanza ad un ceto politico che a tenere aperti spazi di ricerca di nuove vie di liberazione.
Se non fosse che di questo vecchio meccanismo è stato un maestro, mi verrebbe da dire che forse ha ragione Fausto Bertinotti quando afferma che la sinistra dovrebbe saltare un giro. Ma così come non s'impara dalle lezioni, analogamente temo che la scelta dell'Aventino non metterebbe al lavoro nessuna nuova comunità di pensiero.
Che pure c'è e che – dentro e fuori ciò che rimane dei corpi intermedi – stiamo incontrando nel nostro “Viaggio nella solitudine della politica” (www.zerosifr.eu). E' da questo insieme di esperienze e di solitudini che vale la pena ripartire affinché un diverso approccio sulle grandi contraddizioni del nostro tempo provi a declinarle in maniera diversa, alla luce della complessità, dell'interdipendenza e del limite.
Noi siamo qui, in questo passaggio di tempo fra il “non più” e il “non ancora” (ne parlo diffusamente in http://www.michelenardelli.it/uploaded/documenti/tra%20passato%20e%20futuro(2).pdf). Fra una politica (in senso lato) che si attarda a presidiare il “non più” e la solitudine di chi prova ad indagare il “non ancora”. Mondi che s'intrecciano nel cercare le strade per rendere diffusa la consapevolezza di questo tempo.
0 commenti all'articolo - torna indietro
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Consiglio provinciale
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi
- “Il monito della ninfea”
- “Sicurezza”