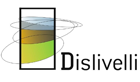«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»
Manifesto di Ventotene
Labirinto Balcanico
Intervento alla Scuola estiva del PD - Cortona 2008
Grazie per questo invito, particolarmente gradito perché dei Balcani se ne parla soltanto quando scorre il sangue. Avere dunque la possibilità di parlarne nell’ambito di una scuola di formazione politica mi pare per nulla banale né scontato.
Un approccio oltre l’emergenza che ha trovato ascolto, e credo sia bene partire da qui. Dai Balcani non come di una storia vicina a noi, ma di una vicenda che è parte integrante della nostra storia, perché i Balcani sono la storia dell’Europa di mezzo, del cuore stesso dell’Europa. Parliamo dei flussi culturali, degli straordinari intrecci che qui lungo il corso della storia sono avvenuti.
Dicevo che dei Balcani si parla quando scorre il sangue. Vi invito a leggere il libro forse più importante che è uscito in questi anni sui Balcani, “Immaginando i Balcani” di Maria Todorova, uno straordinario affresco sull’Europa di mezzo. Credo però che questa disattenzione, la superficialità con cui si è guardato agli anni ’90 e ai messaggi che ci arrivavano nella disintegrazione della Jugoslavia, non riguardi solo i mass media. Riguarda un po’ tutti, la politica in primo luogo. Ognuno di noi sa bene dov’era l’11 settembre 2001, ricorda un’immagine di quel tragico giorno. Ma se la stessa domanda la riferiamo all’11 luglio 1995, la risposta solo pochissimi sanno rispondere. Perché il nome stesso di Srebrenica, non trasmette le stesse sensazioni di orrore e neppure la grande maggioranza delle persone sanno di che si sta parlando, nonostante le cronache giornalistiche ne abbiano parlato. Il più grande genocidio perpetrato in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, non fa parte della nostra memoria collettiva o, tutt’al più riporta il nostro immaginario, come scrive la Todorova, al fatto che “ancora una volta scorre il sangue nei Balcani”.
Nell’immaginare l’Osservatorio, eravamo stanchi di una politica, ma anche di una società civile, che come prassi rincorre gli avvenimenti, quasi fossero le prime pagine dei giornali a scandirne l’agenda politica. La stessa cooperazione internazionale ci ha abituati a rincorrere gli avvenimenti, nel suo confondersi con l’intervento di emergenza, tanto che da qualche tempo parlo di “circo umanitario”. E’ scomparsa la capacità di indicare visioni, di cogliere i conflitti prima che questi si presentino nelle forme più laceranti.
Come potete capire, sto indicando un problema più generale, che non è riferito soltanto ai Balcani. Credo infatti che uno dei paradossi del nostro tempo sia l’avere a disposizione una quantità inedita di notizie e del non essere mai stati così ignoranti. Siamo in preda ad una sorta di autismo, che ci impedisce di mettere a fuoco quello ciò che accade, come se le informazioni fossero liquide e le parole prive di senso. Un esempio concreto. Durante la seconda guerra del Golfo, s’è imposto il tema dello scontro di civiltà ed i grandi del mondo hanno affermato come il proprio modello di vita non fosse negoziabile. Questa cosa è passata così, senza particolare scandalo, quasi che il non negoziare il proprio modello di vita facesse parte del suo diritto.
Ora, cerchiamo di fermarci un attimo e mettiamo a fuoco questa affermazione. In un contesto di limitatezza planetaria delle risorse, affermare che “il mio sistema di vita non è negozi abile” significa dire che non c’è posto per tutti sulla faccia della terra. Il messaggio è chiaro, eppure non c’è particolare indignazione. Forse perché questa affermazione non è solo dei potenti della Terra, ma riguarda tutti coloro che sono dalla parte degli inclusi e non sono disposti a mettere in discussione nulla dei propri consumi e stili di vita. Ma, a guardare bene, questa affermazione rappresenta uno scarto di pensiero, se così possiamo dire, particolarmente grave, perché le grandi ideologie dell’800 e del ‘900 si ponevano come obiettivo quello di dare una risposta ai problemi dell’insieme dell’umanità, erano appunto pensieri umanistici. Oggi qualcuno teorizza il fatto che non ci sia posto per tutti sulla faccia della terra, e quindi si teorizza apertamente la fine dell’umanesimo.
Uno sguardo distratto, sfocato, che non ci fa vedere nemmeno ciò che ci passa innanzi. Oggi, a differenza del passato, non è che ci mancano gli strumenti di conoscenza; se vogliamo possiamo conoscere. Intanto non dimentichiamo che la conoscenza è dolore e che molto spesso si decide di non voler sapere. Ma non sempre è così e, ciò nonostante, fatichiamo a mettere a fuoco. Anche qui un esempio concreto. All’inizio del 2008 si è molto discusso della questione dell’indipendenza del Kosovo. Anche in questo caso se ne è parlato a ridosso delle scadenze e degli ultimatum, insomma ancora una volta quando ormai i giochi erano fatti. Se vi ricordate, quando si ragionava delle varie ipotesi a confronto sullo status di quella regione, qualcuno paventò il pericolo che l’indipendenza del Kosovo avrebbe potuto produrre un effetto domino nella regione balcanica e non solo, tanto che proprio in quelle settimane si cominciò a parlare di Ossezia del sud, di Abkhazia, paesi che nell’immaginario collettivo nemmeno esistevano, o comunque luoghi per ciascuno di noi difficilmente collocabili anche solo sul piano geografico. Abbiamo visto in questi giorni di guerra quanto la crisi caucasica abbia riportato all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale proprio la vicenda dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud. Associata a questi paesi sconosciuti c’era anche un altro stato, la Transnistria. Su questo paese non c’è ancora la necessaria attenzione, eppure parliamo di Europa, non di un paese dall’altra parte del pianeta, ma di un territorio che è parte integrante dell’Europa. So bene che quando parlo di Transnistria, molte persone si guardano fra loro e si chiedono di che cavolo stia parlando. Eppure, la Transnistria è una paese indipendente da oltre sedici anni, con il quale l’Italia sviluppa attività commerciali analogamente agli Stati Uniti e Russia insieme ai quali siamo primi partner commerciali; ha tanto di confini, un parlamento, un governo, una polizia, batte moneta. Ha, come di dovere, una capitale che si chiama Tiraspol. E un enorme stadio di calcio. Qualche anno fa l’Italia doveva andare a giocare nello stadio Sheriff di Tiraspol, dove si doveva giocare una partita di qualificazione in vista dei mondiali con la Moldova. Poi però intervenne qualcuno e la partita venne giocata a Chisinau, nella capitale della Moldova. Ma c’è un piccolo particolare, che lo stadio di Chisinau contiene meno di 5 mila persone, mentre lo stadio di Tiraspol ne contiene 60.000, è coperto e riscaldato. E’ lo stadio di una capitale di un paese fantasma, che per i più nemmeno esiste (mi piacerebbe fare un’inchiesta fra i parlamentari italiani…), che non è riconosciuto da nessuno tranne che dalla Russia. Malgrado ciò ritengo sia fondamentale conoscere e mettere a fuoco. Per comprendere il nostro tempo. La Transnistria, lo dico per quelli che non lo sanno, ma basta che andiate su Google, è quella lingua che sta ad oriente del fiume Nistru e che, nel 1992, di fronte alla dichiarazione di indipendenza della Moldova, a sua volta si autoproclamò repubblica indipendente. In pochi se ne sono occupati, ma il fatto che nessuno se ne occupi non significa che sia meno importante, perché oggi la Transnistria, lo dicono le relazioni dell’Interpol, è fra le principali centrali del traffico internazionale di armi e di esseri umani in Europa.
Allora, siccome il nostro è il tempo dell’interdipendenza credo che non possiamo permetterci di non avere uno sguardo attento su queste cose. Altro piccolo particolare di questo paese. Quando faceva parte dell’Unione Sovietica, vicino a Tiraspol c’era una delle grandi basi militari della vecchia Unione Sovietica, tanto che si parla di un deposito militare di 40.000 tonnellate di armi convenzionali, chimiche, batteriologiche nonché agenti radioattivi impiegabili per la preparazione “artigianale” di ordigni nucleari. In quali mani? Si sa che le mafie internazionali interagiscono con la mafia transnistriana e armi provenienti da quei depositi sono state sequestrate in diverse operazioni internazionali. Ora, la Moldova è un pezzo dell’Europa contigua alla Penisola Balcanica, i traffici di armi che passano da quel paese arrivano in Medio Oriente, arrivano in Europa e nel resto del mondo. Insomma, parliamo di noi.
L’esempio della Transnistria, che pure è ai margini dell’area balcanica, ci è utile per comprendere non solo il nostro appannamento nel comprendere il nostro tempo e le sue trasformazioni ma anche perché credo che le dinamiche che andremo a vedere – e che riguardano la formazione di nuovi stati all’interno della regione – hanno molto a che fare con le dinamiche che hanno portato alla costituzione della Transnistria, dove la dimensione etnica e nazionale (anticipo alcuni concetti che poi andremo ad approfondire) non c’entra assolutamente nulla. Per dire che nella formazione di stati di questo tipo il nazionalismo non c’entra, anche se quest’ultimo viene agitato come elemento di coesione nazionale. Hanno a che vedere, invece, con i nodi della “postmodernità”, cioè con la formazione di stati-mafia, stati offshore che si collocano come retroterra nei processi di finanziarizzazione dell’economia. Quindi, dobbiamo avere attenzione a tali dinamiche perché altrimenti non comprendiamo il contesto con il quale abbiamo a che fare.
Ritorniamo ai Balcani, al cuore dell’Europa. Quando parliamo del Mediterraneo, facciamo fatica ad associare i Balcani al vecchio mare. Vi invito allora ad un’altra lettura fondamentale, Fernand Braudel e il suo straordinario “Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II”. I Balcani sono una delle cinque penisole del Mediterraneo, c’è una storia comune: da Valona a Otranto, ci sono 60 chilometri di distanza e durane le notti d’estate si vedono le luci dall’altra parte; eppure questa vicinanza corrisponde ad una grande lontananza, perché noi di questi paesi non conosciamo le lingue, non conosciamo la storia, non conosciamo le culture. Conosciamo gli stereotipi, invece, e abbiamo grande difficoltà a capire quel che è avvenuto e quello che sta avvenendo. L’amico che mi ha presentato anticipava un’immagine che ci fa ben capire la centralità dei Balcani nei processi europei, ovvero che il Novecento, il secolo che ci siamo messi alle spalle da poco, inizia a muore a Sarajevo: inizia con l’assassinio del 28 giugno 1914 dell’arciduca Francesco Ferdinando, che porterà alla prima guerra mondiale, e si conclude con l’assedio di Sarajevo, nella guerra dei dieci anni. Sì, perché abbiamo avuto una guerra che è durata grosso modo dieci anni alle porte di casa nostra, guardandola in maniera distratta se non rimuovendola.
Prima di entrare nel merito della riflessione che vi voglio proporre e ancora proprio sulla necessità di mettere a fuoco il nostro presente, mi piace usare la metafora della Bosanska Kafa, un rito ineludibile per chi frequenta la Bosnia Erzegovina. La Bosanska Kafa è il caffè bosniaco o il caffè turco, lo si può chiamare come si vuole. Ivo Andrić, Premio Nobel per la letteratura con “Il ponte sulla Drina”, ha scritto molti altri romanzi. Uno di questi è “La cronaca di Travnik”: narra del confronto a distanza tra il console austriaco e il console francese all’inizio dell’800 in quella che allora era la capitale della Bosnia Erzegovina. Ivo Andrić inizia questo romanzo racconta del caffè di Lutvo, un luogo nei pressi del fiume Sumec a due passi dalla più antica scuola coranica di Bosnia. Lutvo è morto da tanti anni, scrive Andrić, ma è abitudine degli anziani della città andare a prendere un caffè da Lutvo, per scrutare il tempo. E’ questa la metafora della bosanska kafa, darsi il tempo. E’, fra l’altro, proprio questo il titolo di un libro che con Mauro Cereghini abbiamo scritto sulla crisi della cooperazione internazionale. Darsi il tempo per capire quali sono i processi della modernità, per capire quello che sta avvenendo intorno a noi, specie in un momento in cui il nostro passaggio di tempo ci consegna le molte insidie della complessità.
Non vi racconterò dei Balcani associandoli alle tragedie della guerra, delle miserie, del divario tra inclusione ed esclusione che segna questi paesi, dei campi profughi che secondo la comunità internazionale non ci sono più semplicemente perché gli hanno cambiato nome. Nemmeno del ritorno difficile dei profughi, o semplicemente della durezza del vivere, perché non è questo il senso di questo mio contributo. Mi limito invece ad una domanda: “Che cosa abbiamo imparato dalla vicenda balcanica degli ultimi 15 anni?” Cosa ha imparato la politica, cosa hanno imparato la società civile, cosa ha imparato la cooperazione internazionale? Perché i Balcani hanno continuato a mandarci messaggi, che noi non abbiamo saputo ascoltare. Ecco, è di questi messaggi che vi voglio parlare.
Il primo messaggio è quello riconducibile al concetto di postmodernità. Uno dei tanti stereotipi con cui abbiamo a che fare è la descrizione dei Balcani come luoghi di guerre arcaiche: credo non vi sia niente di più falso e di fuorviante di questo. Certo, la storia pesa nelle vicende balcaniche, indiscutibilmente; ma guardare a questa regione con la lente di chi dice che lì sono un po’ matti, sono sempre in guerra… come pure hanno fatto eminenti esponenti della diplomazia internazionale ci porta fuori strada. La stessa cattura di Karadzić è avvenuta cercando di far passare questo cliché come a dire “questo era proprio fuori, un signore della guerra che diventa guru della vita naturale, consulente psicologico, terapeuta o quant’altro”, fa parte di una narrazione stereotipata, che non ci aiuta a capire.
Ogni tanto qualcuno mi chiede perché una volta al mese sono dall’altra parte dell’Adriatico. La risposta non è la solidarietà, anche se molte iniziative vanno in questa direzione. La risposta più vera è che la frequentazione balcanica mi aiuta a comprendere le dinamiche del nostro tempo. I Balcani sono come una lente di ingrandimento sul nostro presente: guardando quello che accade in quella regione possiamo capire e vedere in forma più nitida quello che abbiamo intorno a noi. E’ lo strabismo che ci aiuta a guardare le cose anche da un’alta angolazione, perché ci permette di vederle meglio. Dai Balcani ho imparato a guadare la mia terra e la mia città in maniera diversa, comprendendo dinamiche che forse altrimenti non avrei capito.
Quando parlo di postmodernità, mi riferisco ad esempio ai processi di finanziarizzazione dell’economia. In questa sala prima di me c’era il prof. Targetti che ha parlato delle dinamiche della finanza internazionale. L’ho ascoltato con molta attenzione nella sua lucida esposizione, ma vorrei fargli un appunto perché ha omesso un piccolo particolare e cioè il fatto che oggi la movimentazione di capitali finanziari al mondo è cinque volte quello relativo alla produzione di beni e di servizi. Anzi, secondo le ultime stime la sola partita dei titoli “derivati” ha un giro d’affari che è dieci volte il PIL mondiale. In altre parole, la finanza internazionale ha ormai un peso determinante rispetto all’insieme dell’economia mondiale. Quali sono i meccanismi che presiedono alla finanziarizzazione dell’economia? Li potremmo descrivere attraverso il ruolo preponderante delle holding, per cui ormai sempre di più è la dimensione finanziaria a segnare le strategie aziendali.
Provo invece a semplificare questo ragionamento. Cosa accade quando voi andate nella vostra banca di fiducia con qualche risparmio? La prima cosa che vi chiede il vostro consulente finanziario o l’agente di banca è: vuole un investimento prudente o un investimento effervescente? Nel caso vogliamo una rendita maggiore, o forse al di là di come si risponde, il denaro che noi depositiamo a Cortona immediatamente entra in circuito globale, senza confini. Ma in questa circolazione virtuale, il denaro non produce denaro. Per materializzare una rendita questo denaro deve scendere a terra, deve incontrare gli ambiti o le aree di massima deregolazione. Sono le guerre, il traffico internazionale dei rifiuti o quello degli esseri umani, lo stoccaggio del plutonio, la droga, le armi, il riciclaggio che ne segue… sono questi i luoghi in cui avvengono i processi più hard dell’economia finanziaria.
E allora dobbiamo cominciare a guardare a queste realtà attraverso un’altra lente di ingrandimento. Ecco perché è cruciale parlare della Transnistria. Pensate al fatto che la centrale nucleare di Caorso, che era l’unica centrale italiana che era già in funzione prima che il referendum popolare mettesse fine al nucleare in Italia, ha ancora una buona parte dei dipendenti di venti anni fa semplicemente perché non esiste in Italia un luogo per lo stoccaggio del plutonio, perché le 1037 barre di plutonio sono ancora lì. Pensate a quale diseconomia o a quale altra economia corrispondono. E pensate al fatto che la Russia di Putin è diventata in questi anni la discarica mondiale del plutonio esaurito.
Dovremmo iniziare a leggere i tratti della modernità attraverso griglie interpretative che corrispondono solo parzialmente alle categorie classiche dell’economia, ma che sono pertinenti invece ad un contesto nuovo, la postmodernità.
Quando parliamo ad esempio delle guerre balcaniche, non dobbiamo pensare a quel che è accaduto negli anni ’90 come a “guerre etniche”, perché questa chiave rischia di portarci fuori strada. Certo, queste erano le motivazioni che venivano agitate per far sì che la gente si scannasse per tre anni e mezzo in Bosnia Erzegovina (è difficile che qualcuno sia disposto a morire per gli affari di qualcuno), ma guardate che questo è stato il grande imbroglio di quelle guerre.
Mettere a fuoco in questo caso significa indagare queste vicende attraverso altre chiavi di lettura per scoprire che nei Balcani si è giocata (e si gioca) una partita tutt’altro che “arcaica”, che qui più che altrove si materializza la finanziarizzazione dell’economia. Non ci sono soltanto le isole Cayman, c’è anche Cipro che ha fatto da cassaforte di quelle guerre. Ma dietro dietro le casseforti del riciclaggio ci sono i luoghi in cui vengono prodotti enormi profitti attraverso operazioni di rapina, traffici internazionali, stoccaggio di rifiuti ed altro ancora.
Per evitare di parlarne astrattamente, vi propongo un episodio che fa parte del mio vissuto personale. Vi dicevo che tra le mie varie attività c’è anche quella della cooperazione. Bene. Quando nel marzo del 1996 andai per la prima volta a Prijedor, in Bosnia Erzegovina, avevo come interlocutore (fra gli altri) anche il sindaco di allora, Milomir Stakić, che qualche anno dopo venne condannato all’ergastolo dal Tribunale penale internazionale dell’Aja come criminale di guerra. Prijedor era la città simbolo della pulizia etnica e nel tentativo di avviare con quella difficile realtà una relazione che la facesse uscire dal suo incubo, scegliemmo di abitare quel conflitto, di andare nella tana del lupo. Ma questa è un’altra storia. Nella prima occasione d’incontro con Stakić e la nomenclatura della città, nel corso della conversazione gli chiesi quali prospettive immaginasse per la “Republika Srpska” che allora, per la cronaca, aveva come presidente Radovan Karadzić, la cui immagine incombeva in ogni ufficio pubblico di quella parte di Bosnia. Mi rispose in maniera assolutamente tranquilla e lucida: “Penso ad uno stato offshore”. Quella risposta era la chiave per capire quel che era accaduto e che con l’appartenenza etnica non centrava un bottone. I signori della guerra pensavano al territorio da loro controllato come ad un porto franco, un luogo privo di regole se non il loro potere. “Venite con i vostri investimenti – mi disse – qui troverete tutte le condizioni per fare affari vantaggiosi”.
Di fronte alla disgregazione della Jugoslavia, la guerra prima e l’offshore poi costituivano la modalità attraverso cui una nomenclatura succedeva a se stessa, un modo per ripensarsi dentro la modernità. “Noi garantiamo i vostri investimenti perché abbiamo il controllo politico e militare del territorio” era il messaggio, ovvero l’esplicazione di un altro tratto di modernità: la tendenza al neofeudalesimo.
E’ questo il secondo messaggio. I signori della vecchia nomenclatura, che si trasformarono in signori della guerra e che poi sono diventati i signori della terra e degli uomini, lasciata la tuta mimetica indossavano il doppiopetto da uomini d’affari alla ricerca di ogni occasione di business. La possibilità di realizzare una discarica di prodotti tossici avviene soltanto se tu hai il controllo del territorio, perché ovviamente magari qualcuno potrebbe avere l’ardire di arrabbiarsi.
Il neofeudalesimo non è qualcosa che sta nella notte della storia, è qualcosa di profondamente moderno invece, che ha a che vedere con un rapporto di tipo paternalistico tra il capo e il popolo, niente affatto estraneo alla cultura plebiscitaria che segna il nostro tempo. Non è affatto casuale, sempre a proposito di postmodernità e di neofeudalesimo, che una delle prime vicende che annunciarono la disgregazione della vecchia Jugoslavia fu lo scandalo Agrokomerc, forse il più grande kombinat agro-alimentare di quel paese. Il suo presidente si chiamava Fikret Abdić, il quale divenne in seguito uno dei “signori della guerra”, un bosgnacco prima alleato con i serbi poi con i croati, tant’è che era ricercato e condannato a morte dai bosniaci mussulmani. Guarda caso, questo signore si faceva chiamare dalla sua gente “Babo”. Una dinamica di tipo neofeudale, che rappresenta uno dei tratti del nostro tempo.
In questo acquerello qualche altra immagine. E’ quella del presidente della Transnistria, Igor Smirnov, carica che ricopre da 16 anni, titolare con il figlio della Sheriff, la più grande azienda statale (la Transnistria è un paese comunista) e la Sheriff controlla tutti i traffici internazionali, controlla lo stadio, la squadra di calcio e così via. Non so se questo vi ricorda qualcuno…
Solo per dire quanto questi messaggi che i Balcani hanno continuato ad inviarci e che noi in genere non abbiamo saputo raccogliere, ci indichino i tratti di una moderna transizione. I simboli di questa transizione li potete vedere ad occhio nudo andandoci nei Balcani. Sono in primo luogo i centri commerciali che nascono come funghi dalla Romania, alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, luoghi del riciclaggio del denaro, insieme ai casinò. Centri commerciali nei quali non troverete uno straccio di prodotto locale bensì i prodotti dell’economia globale, a testimonianza di un modello economico che sorvola i territori, che li spreme e li omologa. Un secondo simbolo sono le discariche, di cui vi ho già parlato. Il terzo simbolo è la Hummer, un enorme Suv tenuto a battesimo nel 1991 durante la prima guerra del Golfo. Questo carro armato tascabile viene esibito nei Luxury Show, che segnano la vita mondana delle metropoli dei paesi dell’est europeo, ma con un tocco di classe, si fa per dire. La Hummer che viene esibita ha gli accessori dorati e rappresenta lo status symbol dei nuovi ricchi. Immagini attraverso le quali potete comprendere cosa intendo dire con il concetto di postmodernità.
A questo punto, vorrei aprire una piccola parentesi che in questa sede non abbiamo la possibilità di approfondire, ma che mi preme buttar lì, come una domanda – provocazione per una riflessione futura. Possiamo considerare questi paesi come luoghi del sottosviluppo? Credo proprio di no, e non mi riferisco soltanto ai Balcani. Nell’economia mondo non si può più parlare di “Paesi in Via di Sviluppo”, e nemmeno di nord e di sud del mondo come se ne parlava fino a ieri, perché il nord è nel sud e il sud è nel nord e la globalizzazione ha reso a-geografica la divisione fra inclusione ed esclusione, ridisegnando così la geografia politica mondiale. Chiusa la parentesi.
Arriviamo così al terzo messaggio: “le nuove guerre”. Le nuove guerre hanno due scenari di fondo: gli affari, di cui ho appena parlato, e lo “scontro di civiltà”. Non sono guerre fra eserciti, tanto che è dimostrato come le vittime più numerose non siano soldati, bensì le popolazioni civili. Sono guerre che si accaniscono contro i segni della storia e della cultura. E Baghdad, città di straordinarie civiltà, non è in questo molto diversa da Sarajevo. La “Vijećnica”, la biblioteca nazionale di Sarajevo non è stata bruciata perché un colpo è arrivato accidentalmente su quella biblioteca, come non arrivarono accidentalmente nel ’99 sull’Ambasciata cinese a Belgrado. Si voleva colpire la Biblioteca nazionale di Sarajevo per ciò che conteneva, per l’immenso valore storico che sapeva raccontare, così come scelsero di non colpire l’Holiday Inn, ricordo che era praticamente l’unico edificio del centro di Sarajevo che non portava i segni dei bombardamenti, perché si voleva che quell’assedio venisse descritto al mondo dai giornalisti che vi soggiornavano. Sul piano militare l’esercito jugoslavo (o serbo) poteva prendersi Sarajevo in qualsiasi momento, il divario tra le forze in campo era talmente grande… ma non era questo l’obiettivo, le nuove guerre non si pongono necessariamente di conquistare territori, ma sono guerre per segnare degli interessi o per annullare la cultura dell’altro. Bombardare la Biblioteca Nazionale di Sarajevo era come prendere a colpi la storia, era bombardare il cosmopolitismo di quella città e la sua borghesia cittadina, un po’ il simbolo di questo cosmopolitismo. Non a caso intorno alla guerra di Bosnia si è cominciato a parlare di “urbicidio”.
Per descrivere quello che sto dicendo mi piace ricordare l’incontro tra l’allora sindaco di Sarajevo Hamamdzić e l’allora ambasciatore della Federazione jugoslava Lekić, che organizzammo a Roma nel 2002 come Osservatorio sui Balcani. Presentavamo gli avvenimenti organizzati a sostegno dell’appello “L’Europa oltre i confini”, che poi presentammo a Sarajevo con l’allora presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Lekić, nel ricevere Hamamdzić presso l’Ambasciata, si rivolse a lui chiedendo scusa per quello che il suo popolo aveva fatto con l’assedio alla città di Sarajevo e come tutta risposta Hamamdzić disse grosso modo queste parole: «sono felice delle sue scuse che considero per nulla rituali, ma so bene che se l’assedio di Sarajevo è durato tre anni e mezzo è stato perché qualcuno, anche della mia parte, ha voluto che durasse così a lungo». In questa risposta c’è l’essenza delle nuove guerre, degli affari che scorrono anche dietro agli aiuti umanitari visto che anche questi erano oggetto di spartizione tra i soggetti belligeranti, tra le nomenclature che volevano che la guerra durasse perché la guerra era occasione di guadagno. Sul dolore di tanta povera gente, al di là della loro appartenenza nazionale.
Quarto messaggio, l’interdipendenza. Non è semplicemente il “mi riguarda” perché siamo cittadini del mondo. La distinzione tra politica interna e politica estera nel tempo dell’interdipendenza sfuma fino a scomparire. Quel che accade dall’altra parte del pianeta si riverbera in tempo reale sulla nostra vita quotidiana.
Vengo dal Trentino, una terra che amo con una natura straordinaria. Un tempo c’era la perla delle Dolomiti, Madonna di Campiglio. Uno il tempo passato perché quella perla non c’è più o almeno io non la vivo come mia perché lo considero un luogo in qualche modo offshore, ed in effetti i trentini non ci mettono più piede. In quella che un tempo era la perla delle Dolomiti gli appartamenti vengono venduti a 14/15.000 euro al metro quadrato. Gli acquirenti? C’è di tutto, ma chi incombe è la mafia russa. Quello che accade dall’altra parte del mare, ma potrei dire altrove, si riverbera in tempo reale sul nostro presente: parlo dei fenomeni migratori, dei traffici, della criminalità. L’effetto di cifre del genere è la demolizione dell’economia del territorio in nome di un business che non ha alcuna relazione con l’economia di mercato.
Allora tutto questo ci riguarda non solo e non tanto come cittadini solidali ma come territori in relazione con i processi globali e cittadini parte di una comunità di destino terrestre, per usare la bella espressione di Edgar Morin.
Quinto messaggio, “la locanda balcanica”. Riguarda le paure e i nostri fantasmi. Rada Iveković, in “Autopsia dei Balcani”, descrive la filosofia del villaggio, ed un’immagine dalla straordinaria forza evocativa, la balkanska krćma. Dov’è la postmodernità in una baracca di legno sperduta in qualche villaggio fangoso dove si beve rakija? Sta nel conflitto fra città e campagna che incontriamo frequentemente nelle guerre moderne, ma soprattutto è il luogo dove gli umori diventano rancore e il rancore progetto politico. Non è forse questa la modernità? Non è forse questo il meccanismo che di fronte all’incertezza del futuro e al venir meno di una chiara identità sociale fa sì che crescano intorno a noi i fantasmi della paura? O non le sappiamo vedere le tante osterie, le tante locande che abbiamo sotto casa nostra, in cui – appunto – gli umori diventano rancore, le invidie, il dileggio nei confronti degli intellettuali, verso la cultura, verso tutto quello che in qualche modo non ha a che vedere con un immaginario pornografico, per usare l’espressione della Iveković? In realtà tendiamo a non accorgerci di questi “non luoghi” che crescono nelle nostre periferie, più centri commerciali che locande, in cui un’umanità perduta passa le giornate fra consumismo e invidia. E dove nascono leggende metropolitane che a loro volta alimentano stereotipi e paure nelle persone più esposte socialmente e culturalmente. Un’immagine che – fra l’altro – ha a che vedere proprio con la difficoltà tipica del nostro tempo di affrontare la questione della solitudine, i contesti di forte atomizzazione sociale, e nei quali gli strumenti tradizionali dell’emancipazione e della liberazione sono ormai spuntati per i loro tragici esiti. Abitare i conflitti significa anche questo, riconoscere le locande sotto casa e le paure che vi albergano.
Mi viene un’altra immagine. Qualche anno fa parlavo con una giornalista di Belgrado, Mirjana Tomić. Le chiesi qual era stato l’atteggiamento dell’intellettualità belgradese nei confronti di questi personaggi che in breve tempo stavano diventando uomini di stato. Mi riferivo ai Mladić, ai Karadzić, ai Milosević. La sua risposta mi fece venire la pelle d’oca, perché mi disse: «noi ridevamo… quando vedevamo questi personaggi in televisione non li prendevamo sul serio». Tutto questo mi ricorda qualcosa di molto vicino a noi.
Nella descrizione di questo messaggio, quello della locanda, dei fantasmi e delle paure, abbiamo tutti un debito verso Paolo Rumiz e quello che ci ha raccontato nel corso degli anni.
Sesto messaggio, la necessità di mettere in discussione il principio di autodeterminazione dei popoli. Il principio di autodeterminazione dei popoli è uno di capisaldi del diritto internazionale, che è stato nel corso degli anni del post colonialismo il nostro pane quotidiano. Le persone della mia generazione si sono formate nell’impegno terzomondista e coltivando la speranza che il postcolonialismo apriva a livello internazionale e che investiva in primo luogo il diritto di autodeterminazione dei popoli. Quel pensiero aveva come scenario il tempo degli stati nazionali.
Credo che noi oggi si abbia la necessità di un pensiero postnazionale. Il fatto è che noi, nonostante la radicali trasformazioni indotte dalla globalizzazione, continuiamo ad essere immersi nel paradigma dello stato-nazione e fatichiamo ad uscirne. La globalizzazione, paradosso del nostro tempo, sta determinando la proliferazione degli stati. E se noi dovessimo riconoscere statualità ad ogni nazionalità, nella disgregazione dei vecchi imperi o di stati plurinazionali avremmo a che fare con la proliferazione infinita di stati e di conflitti armati. La vicenda del Kosovo sta a testimoniare come i diritti internazionali possano diventare confliggenti, l’autodeterminazione da un lato, la sovranità dall’altro. E di come le soluzioni non negoziali non portino da nessuna parte.
Il messaggio che ci viene dai Balcani è che il concetto di autodeterminazione deve essere profondamente rivisto, a favore di quello di autogoverno e di autonomia. Era un messaggio in negativo. Bisogna dire, a ragion del vero, che in quello stesso tempo altri messaggi venivano da altre longitudini.
Uno di questi porta la data del 1 gennaio 1994. La rivolta indigena del Chiapas – della quale abbiamo visto più il folklore che altro – esprimeva un messaggio straordinario: la rivendicazione di autogoverno non richiedeva la costruzione di nuovi confini, ma paradossalmente l’abbattimento di quelli precedenti. L’autogoverno, non l’autodeterminazione nazionale.
Avverto il bisogno urgente di un pensiero post nazionale. E l’Europa potrebbe essere un progetto che va in questa direzione; l’Europa delle tante minoranze, non l’Europa degli stati, ma l’Europa delle regioni, l’Europa nella quale gli Stati cedono progressivamente la propria sovranità verso nuova dimensione postnazionale, e dove le regioni transnazionali disarticolino i vecchi confini.
Anche da questo punto di vista dai Balcani ci viene un’immagine molto importante. Il luogo che i partecipanti possono vedere nella foto si chiama Blagaj, un villaggio molto bello non lontano da Mostar. Lì, dalla roccia, esce la Buna, il fiume che per quantità d’acqua alla fonte più grande d’Europa. La sua vita in verità è brevissima, perché finisce nella Neretva, cinque chilometri più a valle. E lì accanto c’è l’antica Tekja luogo di culto dei Dervisci. In questo luogo, nel lontano 1463, qualche anno prima della conquista delle Americhe e prima dell’espulsione degli ebrei e dei mori dalla Spagna, il sultano Maometto II Al Fathi scrisse l’Editto di Blagaj. Lo trovate nel materiale che ho mandato per questo seminario ed è considerato una delle prime carte dei diritti dell’uomo . Non c’è lo spazio per trattare a fondo questo argomento, la pluralità delle radici culturali dell’Europa. Ma mi preme ricordare che, lungo la storia, Sarajevo (non a caso chiamata la Gerusalemme dei Balcani) è stata la terra d’asilo degli ebrei safarditi e che durante la seconda guerra mondiale furono le autorità religiose islamiche a salvaguardare i libri sacri della cultura ebraica.
Per tornare a noi e ai messaggi che i Balcani ci hanno inviato in questi anni, credo dovremmo riflettere sulla necessità di andare oltre il paradigma dello Stato nazione, tant’è vero che come Osservatorio sui Balcani abbiamo proposto nei mesi scorsi, purtroppo inascoltati, il fatto che il Kosovo avrebbe potuto diventare – nell’ambito dell’Europa delle regioni – la prima regione europea. Rammarica il fatto che l’Europa che oggi prevale sia quella degli Stati, che c’entra poco o niente con il pensiero federalista di Ventotene.
Infine, un ultimo messaggio, la banalità del male e l’elaborazione dei conflitti. I criminali non sono mostri: sono persone normali. Hannah Arendt ne ha parlato a proposito del processo ad Eichmann nel 1961, per tentare di indagare oltre la dimensione della colpa criminale, la colpa politica e quella morale. Il responsabile dell’organizzazione del sistema concentrazionario della Germania nazista organizzò la sua difesa presentandosi come uno zelante servitore dello stato, e a partire da ciò la Arendt mise a nudo una diffusa responsabilità politica e morale che coinvolgeva un’intera nazione insieme ai paesi che si allearono con il Terzo Reich.
Quel male assoluto riapparve nei Balcani dopo mezzo secolo, lì dove aveva trovato durante la seconda guerra mondiale le maggiori resistenze. Il primo ad ammettere dalla parte dei criminali l’eccidio di Srebrenica fu un ragazzo di 25 anni, Drazen Erdemović. Nella sua testimonianza al Tribunale dell’Aja aprì finalmente una crepa nel silenzio e nell’omertà, ammettendo l’assassinio premeditato in una sola mattinata di oltre mille persone, tanto che alla fine erano stanchi di uccidere. Erdemović dichiarò al TPI che prima che iniziasse la mattanza si rivolse ai suoi superiori chiedendo loro se si rendessero conto di quello che gli stavano ordinando di fare. Gli risposero che se non era d’accordo, avrebbe potuto mettersi dall’altra parte, subendo così la stessa fine di quella povera gente.
Quanti di noi avrebbero avuto il coraggio di mettersi dall’altra parte? Fuori dal luogo dello sterminio, una banale fattoria collettiva, la vita scorreva normalmente, i bar erano affollati di gente indifferente. Per dire che criminali di guerra si diventa trovandosi lì, senza aver mai immaginato di diventare degli assassini. E che responsabili si è anche nell’indifferenza verso quel che accade intorno a te. Le immagini dei paramilitari che sorridono uccidendo persone inermi ci devono far interrogare tanto sulla banalità del male quanto sulla “felicità della guerra” di cui ci ha parlato lo scrittore colombiano Estanislao Zuleta. Ma anche questo concetto meriterebbe una trattazione specifica.
L’altra faccia di questo medesimo messaggio investe la necessità di riconoscere ed elaborare i conflitti. Noi abbiamo in genere paura dei conflitti, tendiamo a rimuoverli anziché elaborarli. A partire dalla semplice considerazione che in assenza di elaborazione i conflitti rimangono lì, come fossero anestetizzati, e non c’è alcuna trasformazione né riconciliazione. Se ne parla molto spesso a vanvera di riconciliazione, quasi che si trattasse di rimuovere ciò che è accaduto. La riconciliazione non è questo, è capire ciò che è avvenuto, è trovare il punto di incontro tra le diverse narrazioni, è elaborazione collettiva del conflitto. Una cosa difficile e costosa, forse più del carcere e di ogni risarcimento.
E’ facile ricostruire le case nei dopoguerra, fare tutte le cose di cui in genere si occupa la cooperazione internazionale. Ma in assenza di elaborazione del conflitto, con ciascuna delle parti chiusa nella propria verità e nel proprio dolore, quel che è accaduto può tornare a ripetersi. Senza elaborazione le ferite rimangono lì, lo possono rimanere per seicento anni, e non lo dico a caso se consideriamo che l’inizio della guerra in Jugoslavia la potremmo simbolicamente datare 28 giugno 1989, esattamente seicento anni dopo quel 28 giugno 1389 della battaglia di Kosovo Polje. Basta che qualche apprendista stregone sia capace di manipolare la memoria divisa, gli stereotipi, le paure ed il gioco è fatto. In Alto Adige/Sud Tirolo, regione nella quale il livello di benessere è tra i più alti in Europa, è bastato che il sindaco di Bolzano decidesse di cambiare il nome della Piazza della Vittoria in Piazza della Pace, che la città si spaccasse tra italiani e tedeschi, a dimostrazione del fatto che il benessere non è sufficiente e che il tempo non è sempre galantuomo. Rimuovere o congelare i conflitti affidandosi al tempo che passa e alle pance piene non porta da nessuna parte. I conflitti dobbiamo vederli, riconoscerli, così come è necessario entrare in comunicazione con l’altro a cominciare dal riconoscerne il dolore.
Abitare ed elaborare i conflitti, mettere a fuoco, darsi il tempo.
0 commenti all'articolo - torna indietro
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Collettivo di scrittura
- Consiglio provinciale 2008-2013
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Il monito della ninfea
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Sicurezza
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi