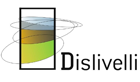"... avevo scoperto l'abisso della rassegnazione, la virtù del distacco, il piacere del pensare pulito, l'ebbrezza della creazione politica, il fremito dell'apparire delle cose impossibili..." Altiero Spinelli
La città del (non) ritorno

Racconto di viaggio, ultima puntata.
di Michele Nardelli
Il racconto del mio viaggio potrebbe finire qui. Ma non sarei onesto con me stesso se non parlassi anche di quel tratto di strada che nemmeno in questa circostanza ho voluto percorrere.
Conosco le strade della Bosnia Erzegovina come quelle della mia terra. Per averle percorse centinaia di volte nel dopoguerra, fra aiuti umanitari e una cooperazione che voleva essere diversa. E poi, soprattutto, per capire. Per cercare di comprendere quel che stava accadendo in Europa, come era potuto accadere che dopo mezzo secolo di “fratellanza e unità” tutto fosse andato in frantumi in forme così cruente. Per entrare nelle sfumature, nella psicologia sociale, nel genio dei luoghi.
Non è stato affatto tempo buttato alle ortiche, perché tutto questo mi ha permesso di avere uno sguardo nuovo sul mio tempo. Quello strabismo che mi ha insegnato ad osservare la realtà da prospettive diverse, per avere una diversa profondità nel leggere gli avvenimenti, ricevendo ben più di quanto abbia potuto dare sul piano della solidarietà o della progettualità messa in campo in questi anni. Devo riconoscere di aver costruito così la mia cittadinanza europea, con quel qualcosa di più che viene dal trovarti all'incrocio fra oriente e occidente, fra continente e mediterraneo, che solo i Balcani ti possono dare.
In questo infinito viaggiare, la città di Prijedor ha avuto un ruolo decisivo. Tanto per cominciare ha rappresentato il mio primo contatto con la guerra, quella reale che la mia generazione poteva toccare con mano perché sull'uscio di casa. Avrò per sempre negli occhi le case di Kozarac1 di cui rimanevano le spettrali scatole annerite, il villaggio di Hambarine dove tutto era divelto per scongiurare il ritorno2, la cittadina di Ljubija dove sorgeva la grande miniera di ferro a cielo aperto usata durante la guerra come fossa comune e ridotta ad un immenso campo profughi... l'incontro con i signori della guerra, personaggi inquietanti che loro malgrado mi hanno aperto gli occhi sulla postmodernità.
Nel 1996 prendemmo3 per mano quella città, nell'improbabile tentativo di farla uscire dal gorgo maledetto in cui si era cacciata quattro anni prima diventando “la capitale inaccessibile”4 di un nazionalismo che in realtà nascondeva un'operazione di gangsterismo ordita da un gruppo di potere il cui interesse stava nella rapida accumulazione di denaro e beni.
Non voglio qui ripetere ciò che questa città ha rappresentato durante la guerra di Bosnia, esercizio di sperimentazione delle nuove guerre seguite alla caduta del muro di Berlino. Né tanto meno ripercorrere lo straordinario lavoro di diplomazia popolare e di cooperazione di comunità proseguito per più di un decennio e che ha coinvolto un segmento significativo dell'impegno per la pace attraverso la generosità e l'intelligenza di tante persone nella mia terra (se volete approfondire, con Mauro Cereghini ne abbiamo parlato diffusamente in “Darsi il tempo”5).
Intendo invece dire due cose sul perché, pur ripercorrendo le affezionate rotte balcaniche, a Prijedor non ho messo piede da più di cinque anni. Eppure se questa città in una certa misura si è scrollata di dosso l'immagine della pulizia etnica, diventando nel dopoguerra “la città del ritorno”, lo si deve proprio al lavoro di tante persone che, insieme a me, hanno creduto in una diversa cooperazione che andasse oltre la dimensione umanitaria.
Quando, dopo dieci anni di frequentazioni assidue e di attività che non trascuravano nulla della condizione umana in quella città, posi all'assemblea del Progetto Prijedor la necessità di impegnarci a fondo per far emergere dalle macerie una nuova classe dirigente, mettendo da parte la logica degli aiuti (senza per questo rinunciarvi) e proponendoci di investire più di quanto non avessimo fatto fino a quel punto in attività culturali e nell'elaborazione del conflitto, prevalse un altro approccio.
Dovevo capirlo da subito, la logica degli aiuti non chiede a nessuno di mettersi in gioco, non sfiora la (falsa) coscienza di alcuno, né ti porta in conflitto con i nuovi potenti che sulla divisione etnica hanno fatto i loro interessi e costruito il loro potere. Se il sindaco di Prijedor era il vecchio direttore delle Poste che aveva svolto un ruolo cruciale nell'operazione di esproprio organizzato come venne evidenziato dal rapporto Mazowiecki6, pazienza. L'ingerenza che ci portò in rotta di collisione con i “signori della guerra” e che contribuì in maniera decisiva a rendere possibile l'avvio del ritorno delle popolazioni che avevano subito la pulizia etnica, il duro confronto attorno alla narrazione di quanto era accaduto negli anni '90 che avviammo con la costruzione del “Forum Civico” e con il “Progetto memoria”, non erano più nelle corde del progetto al quale avevo dato anni di lavoro. Pazienza. Forse richiedeva un coinvolgimento troppo forte, forse qualcosa che sembrava più grande di noi. Difficile anche qui...
Nella sala mi guardavo attorno, troppe persone che a quella sfida avevano creduto non c'erano più, qualcuno mi considerava un matto che insisteva nel voler cambiare il mondo, altri proprio non capivano. Personalmente non avevo voglia di perdere tempo con la “banalità del bene”, né tanto meno con la cattiveria dell'ignoranza. Lo dissi senza ritrosia, né rancore... e me ne andai.
Così la strada per Prijedor non l'ho più voluta imboccare. Con la nostalgia per le tante persone care, con il dispiacere di non dare spiegazioni per evitare di mettere le persone nell'imbarazzo di doversi schierare magari mettendo in discussione la fedeltà al capo, con il rammarico del sentirti dire a mezza voce (anche perché “i buoni” sanno essere vendicativi) che non era più come prima.
Spero solo rimangano le tracce di questo lavoro, se non nelle cose almeno nelle persone. Anche perché quel che sembrava impossibile ad un certo punto è iniziato ad accadere. Non dimenticherò mai le parole dell'amico Sead Jakupović, oggi presidente del Consiglio Comunale di Prijedor, quando mi disse che nemmeno potevamo immaginare quanto fosse stata decisiva la nostra presenza nel favorire il ritorno della sua gente a Prijedor.
So che la città, rispetto a quella che ho conosciuto nell'immediato dopoguerra, è oggi quasi irriconoscibile, che i segni della tragedia sono – agli occhi del visitatore – praticamente scomparsi, che l'arredo urbano è molto curato, che a dispetto della situazione in Bosnia Erzegovina a Prijedor sembra esserci un fervore economico altrove inesistente. Eppure a Omarska7, laddove nella primavera del 1992 fra i capannoni della grande miniera riapparve lo spettro dei campi di concentramento, non c'è un memoriale a ricordo di chi vi ha perso la vita, nemmeno un segno a testimoniare che in quella casa bianca dove si svolgevano interrogatori e torture passarono migliaia di persone. Come avveniva negli anni del dopoguerra bosniaco, la proprietà anglo-indiana della miniera, il colosso mondiale dell'acciaio Mittal che ha realizzato la grande torre per le Olimpiadi 2012 di Londra (l'ArcelorMittal Orbit), allontana gli estranei che intendono mettere un fiore in quel luogo dove persero la vita centinaia di persone.
No, nemmeno in questo viaggio in libertà, dove pure l'idea di ritornare sui miei passi l'avevo messa in conto, alla fine ho voluto far ritorno a Prijedor.
1. Centro abitato a pochi chilometri da Prijedor in cui vivevano migliaia di famiglie bosniache
2. «Con le loro moschee non bisogna limitarsi a distruggere i minareti, bisogna ribaltarne le fondamenta, cosicché non possano più ricostruirle. Se fai questo se ne vanno, se ne vanno per conto loro» Dichiarazione rilasciata dal capo della polizia di Prijedor Simo Drljača, “il più potente signore della guerra a Prijedor”. In “La guerra in casa” di Luca Rastello, Einaudi, pag.219
3. Mi riferisco ai volontari della Casa per la Pace di Trento
4. Luca Rastello, “La guerra in casa”. Einaudi, 1998
5. Mauro Cereghini e Michele Nardelli, Darsi il tempo. Emi, 2008
6. «... servì per favorire le transazioni finanziarie necessarie. Era evidente che sotto il comando di Pavić l'ufficio postale era usato, fra l'altro per drenare e ripulire denaro durante la presa della città». Citato in “La guerra in casa”, ibidem.
7. Il campo di Omarska era il principale centro di concentramento delle vittime della pulizia etnica nella municipalità di Prijedor
1 commenti all'articolo - torna indietro
-
inviato da Annalisa il 20 settembre 2014 13:35
 Bijela kuca, Omarska...
Bijela kuca, Omarska...
Mi spiace tu non sia passato a Prijedor. Molti ti vedrebbero con piacere ed inoltre è interessante anche lo sguardo disincantato ma appassionato di chi come te ha dato moltissimo a quella città.
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Consiglio provinciale
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi
- “Il monito della ninfea”
- “Sicurezza”