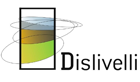«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»
Manifesto di Ventotene
La caduta di un muro. La fine di una storia e il vuoto di pensiero che non siamo stati capaci di riempire.

«La maledizione di vivere tempi interessanti» (98)
di Michele Nardelli
Come per ogni data che segna un passaggio importante della storia, anche il 9 novembre porta con sé le insidie delle celebrazioni. Il trentennale della caduta del muro di Berlino non sfugge a tali insidie, bastava dare un'occhiata ai talk show televisivi ad esso dedicati per rendersene conto.
Anche testimonianze interessanti e qualche (rara) riflessione, sia chiaro. E credo comunque che ritornare su quei giorni, sul loro significato, sulle grandi aspettative che si aprirono e sugli esiti che con quelle aspettative ben poco avevano a che fare, possa essere non solo utile ma anche necessario.
Perché di certo il 9 novembre 1989 finì una storia, quella di un Novecento denso di speranze e di tragedie e non ancora sufficientemente elaborato. Ai sorrisi e agli abbracci sulla Porta di Brandeburgo seguì un'altra storia, da quel che abbiamo potuto constatare in questi trent'anni non certo priva di scenari inquietanti (di guerre e almeno due genocidi), quanto avara di idee e di aspirazioni collettive.
In questa nota – che scelgo di scrivere nei giorni successivi al 9 novembre proprio perché ritengo che l'oggetto di questa riflessione dovrebbe esulare dal calendario – non intendo aggiungere altre parole a quanto già scritto su quegli avvenimenti.
Vorrei piuttosto interrogarmi sul presente, per provare a comprendere se c'è e, nel caso, quale sia il filo rosso che congiunge quel che sta accadendo nelle strade e nelle piazze di Barcellona e di Londra, di Baghdad e di Diyarbakyr, di Hong Kong e di Beirut, di La Paz e di Santiago del Cile, e il vuoto politico e culturale che la fine di una storia ha lasciato dietro di sé.
Nessun fraintendimento. Quel muro, eretto dalla DDR a difesa della propria incontaminazione con il modello capitalistico, non esprimeva affatto una visione del mondo alternativa, bensì un altro potere. Semmai lo sgretolarsi del muro di Berlino e gli avvenimenti che ne seguirono avrebbero potuto evidenziare la fine di un inganno: l'idea che un mondo egualitario (o che così diceva di essere) potesse reggersi sulla negazione della libertà, sulla repressione verso il pensiero e lo spirito critico, sullo stato di polizia e i carri armati. Senza non dirci che quel muro faceva comodo in realtà anche all'Occidente, ne testimoniava la superiorità, un assist della stupidità che durò per ventotto anni.
Mentre scrivo mi accorgo che la penna va per i fatti suoi, che avrei voglia di ripercorrere anch'io quei giorni convulsi e straordinari, perché vi assistemmo in diretta, perché cambiò un mondo che sembrava immodificabile, perché cambiammo anche noi e perché proprio in quei giorni, anzi proprio in quelle ore, con l'ultimo congresso di DP del Trentino demmo il là alla nascita di Solidarietà, quel soggetto politico territoriale che ci aiutò ad attraversare in forma creativa un passaggio di tempo nel quale si sgretolavano ideologie ed appartenenze. Sembrava impossibile che accadesse, ma eravamo sul pezzo. Ma non è di questo che però ora voglio parlare.
Guardando in questi giorni alle piazze di mezzo mondo che rivendicano lo stato di diritto, pensando ad un inedito prendere la parola dei giovani che a partire dall'ambiente s'interrogano sul loro futuro, vi leggo qualcosa di non riconducibile ad una rivendicazione particolaristica e nemmeno comprimibile dentro un angusto spazio politico nazionale. C'è qualcosa che ha a che fare con i grandi temi del nostro tempo, dopo aver preso atto che il pensiero unico dominante sta portando l'umanità e il pianeta sull'orlo del baratro. Assomiglia, mi permetto di dire, a ciò che rappresentavano le “primavere” per il mondo arabo, prima che le lasciassimo sfiorire.
Forse anche per questo vi leggo la solitudine. Perché in quelle moltitudini emerge qualcosa di disperatamente necessario, un'idea diversa di futuro e di una nuova leadership collettiva. Ma l'una e l'altra non ci sono.
In tempi non sospetti ho parlato di nuovo umanesimo (ormai le parole vengono ingoiate nel tritacarne mediatico tanto da svuotarle di significato), anche se non so se sia questo il concetto più corretto per esprimere quel cambio di paradigma che da tempo (e non da solo) vado auspicando.
Un nuovo umanesimo (quello vecchio è stato ipocrita e privo di mondo), perché il neoliberismo ha messo in conto di condannare alla deriva qualche miliardo di persone (cos'è questa se non la terza guerra mondiale), ma anche per sentirci vicini ad altre solitudini, quella di Francesco, ad esempio, quando nella Laudato sì scrive: «Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di rispondere alla necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future. Si rende indispensabile – prosegue Francesco – creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia»1.
Proprio così. Un cambio profondo nel pensiero, nuove leadership. Un tempo si diceva che le idee camminano sulle gambe degli uomini (l'antropocentrismo era pure al maschile). Ma nell'indistinta nebbia dell'atomizzazione sociale, dove le classi – per usare il vecchio adagio di Karl Marx – non sono più né in sé, né per sé, chi sarebbero questi “uomini” o, se si vuole, questi soggetti sociali? E' forse, come sosteneva il movimento Occupy Wall Street, il 99 per cento che non possiede nulla contro l'1 per cento che possiede tutto?
Il fatto è che ciò che rimane della classe operaia, o se preferite il concetto più indistinto di lavoratori, non intende rinunciare al proprio status per quanto relativo vissuto come insidiato da qualche disgraziato che in un vicino altrove fa il suo stesso lavoro per un decimo del proprio stipendio con il quale a malapena arriva alla fine del mese. E che i poveri o, forse meglio, gli esclusi hanno come massima aspirazione quella di essere dall'altra parte. Senza dimenticare che c'è sempre qualcuno di più disgraziato con cui essere in competizione.
E' questo l'esito della fine di una storia, quella che considerava il conflitto fra le classi sociali nella sua irriducibilità come il motore della civiltà. Non è solo o tanto la fine della spinta propulsiva dell'ottobre sovietico (che pure non faceva sognare più nessuno), è la sconfitta di un movimento che si fondava sull'emancipazione dal bisogno ma che, a guarder bene, esprimeva una profonda subalternità dell'uomo al possesso di cose.
Quel che rimane è dunque un vuoto profondo. E' l'esaurirsi del paradigma moderno che dalla rivoluzione industriale aveva fondato un modo di guardare alle cose del mondo, alle classi sociali, allo Stato, alle forme di organizzazione della politica. Abita qui l'incapacità di affrontare le tante crisi che si aprono di fronte a noi e alle quali continuiamo a dare risposte obsolete con il solo effetto di ingigantirle. Le piazze di Barcellona e di Londra, di Baghdad o di Diyarbakyr, di Hong Kong e di Beirut, di La Paz o di Santiago del Cile, ci parlano di questo. Così come l'Ilva di Taranto o l'Alitalia, lasciti di un vecchio paradigma che andrebbero affrontati con uno sguardo diverso, sovranazionale e capace di far propria la cultura del limite.
Penso che la riflessione su quel muro abbattuto dovrebbe servire a questo, a scrutare il futuro avendo fatto tesoro del passato.
1Francesco, Laudato sì. Lettera enciclica sulla cura della casa comune. Ancora, 2015
0 commenti all'articolo - torna indietro
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Collettivo di scrittura
- Consiglio provinciale 2008-2013
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Il monito della ninfea
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Sicurezza
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi