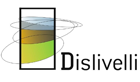«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»
Manifesto di Ventotene
Cosa significa essere poveri? Una denuncia e qualche traccia di lavoro.

di Federico Zappini
Socialismo o barbarie. Il celebre motto di Rosa Luxemburg risuona oggi con una pregnanza che impressiona. Non si tratta di nostalgia ideologica o di una provocazione. Il sistema neoliberista accumula macerie – crisi ricorrenti, premesse di collasso ecologico, moltiplicazione dei fronti di guerra a “normalizzazione” dell’instabilità globale – tanto da ostruire ogni proiezione verso destini desiderabili. Non stupisce che l’uso della forza diventi il linguaggio utilizzato per intervenire in ogni questione, geopolitica, economica o migratoria che sia.
È di fronte a questo quadro destabilizzato che dobbiamo collocare la questione cruciale del nostro tempo, ossia la sfida per la giustizia sociale. Al centro di questa sfida sta il tema delle povertà, vlutamente poste al plurale per descriverne la varietà di cause e conseguenze.
Non si scappa dai numeri
Non mancano i numeri per analizzare i contorni del fenomeno. Anzi, essi compongono ormai un doloroso rosario. L’ultimo rapporto in ordine di tempo è quello nel quale Caritas fotografa un aumento del 62% delle richieste di supporto nell’arco di dieci anni (2014/2024), intercettando nella prossimità dei propri centri l’ampliarsi delle fragilità che colpiscono famiglie e singoli, in particolare anziani o lavoratori poveri tra i 35 e i 50 anni. Si tratta della spia di una tendenza che attraversa la società italiana.
I dati sui tassi di disuguaglianza prodotti da OXFAM sono impietosi: il 5% più ricco delle famiglie italiane controlla quasi il 48% della ricchezza nazionale, una quota che supera quella posseduta dal 90% più povero della popolazione.
L’ISTAT nel 2025 ha suonato altri campanelli d’allarme. Il 23,1% della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale. La povertà assoluta colpisce l’8,4% delle famiglie, percentuale che sale al 12,4% quando si tratta di famiglie con figli. Circa 1,3 milioni di minori vivono in condizioni di povertà assoluta. La crescita economica rimane debole, con l’Italia che continua a rimanere indietro rispetto a Francia e Spagna anche su salari e produttività, mentre il potere d’acquisto delle famiglie è sotto pressione costante, mentre c’è da attendersi un’ulteriore fiammata inflazionistica a valle dell’allargarsi del conflitto nel vicino oriente.
Il CENSIS aggiunge ulteriori tasselli al mosaico della crisi. Il reddito disponibile pro capite si è ridotto negli ultimi vent’anni, di fatto peggiore performance in Europa. Cresce contestualmente la difficoltà di accesso ai servizi essenziali – sanità, sostegno sociale, istruzione – soprattutto per le fasce più vulnerabili, anche a causa della riduzione degli interventi pubblici e un diffuso processo di privatizzazione.
A questa fotografia impietosa dobbiamo connettere due informazioni che completano la descrizione della “nuova normalità” dentro cui viviamo. Laprima. La produzione industriale italiana è in contrazione continua da ormai due anni, a conferma di un’economia infragilita che moltiplica i lavori poveri (anche e soprattutto per i settori – come il turismo – che ha deciso di far diventare primari) e le occupazioni precarie. La seconda. Cresce il numero di under 35 che decidono di lasciare l’Italia – 350mila in dieci anni -, alla ricerca di migliori opportunità di lavoro e salari adeguati. Un’emorragia che priva il Paese delle sue energie più dinamiche e formate. Un’ulteriore gravosa ipoteca sul futuro.
Quando la povertà diventa una tendenza esistenziale
Questo avvitamento nella povertà schiaccia una fetta sempre più ampia di popolazione. Genera un diffuso senso di inquietudine che qualcuno tenta anche di sfruttare per fini elettorali – di sicurezza infatti si parla spesso, a sproposito – invece di prendersene carico, ed erode progressivamente le certezze di quello che un tempo definivamo ceto medio. Lo hanno descritto con lucidità le ACLI Trentine nel loro ultimo rapporto, lanciando un segnale d’allarme in un territorio che si è sempre distinto in termini di tenuta sociale. Se anche il Trentino vacilla – e Il T da mesi approfondisce meritoriamente il tema –, significa che il fenomeno ha raggiunto una tale profondità da non risparmiare nemmeno le aree tradizionalmente più solide del Paese.
Alice Facchini – nel suo libro Poveri noi– ha scelto di raccontare come la povertà penetri dentro ogni aspetto dell’esistenza di una persona, contaminandola e rendendola faticosa e pericolosa al punto da chiudere ogni spiraglio di futuro. La povertà materiale – di cui abbiamo parlato fin qui – si trasforma in un virus che contagia ogni ambito della vita. Diventa povertà alimentare, con conseguenze sulla salute che poi trova risposte insufficienti nella sanità pubblica. Deriva da o produce povertà energetica e povertà abitativa, rendendo la casa un privilegio e non un diritto. Esonda nella povertà relazionale – che lascia soli e indifesi – e in quella educativa, rendendo in questa maniera ancora più complicata la riattivazione di un’ascensore sociale da anni guasto.
L’impoverimento come tendenza per fasce sempre più ampie di popolazione diventa facilmente un coagulo di dolore che amplifica insoddisfazione nei confronti di decisori politici ritenuti incapaci di garantire una vita dignitosa e incanala la rabbia nei confronti di un Altro da sé che si percepisce come minaccia al proprio benessere in declino. E’ la storia dei “forgotten man” (i cosiddetti perdenti della globalizzazione) delle aree extraurbane americane, e non solo.
L’economista spagnolo Andrés Rodríguez-Pose ha descritto con precisione quello che chiama trappola dello sviluppo. Territori e comunità che perdono dinamismo e capacità innovativa – i dati trentini da questo punto vista non lasciano tranquilli – entrano in una spirale di stagnazione da cui è sempre più difficile uscire. La povertà genera abbandono, l’abbandono apre a povertà cronicizzata, in un circolo vizioso che rischia di produrre vere e proprie zone di marginalità economica e sociale.
La cura è nella comunità e nelle sue alleanze generative.
Che fare, allora? Serve innanzitutto abbandonare la retorica dell’emergenza per abbracciare la logica della trasformazione strutturale e per farlo è necessaria una grande alleanza tra diversi – istituzioni, imprese, terzo settore, organizzazioni sindacali, realtà culturali, cittadin* consapevol* – con l’obiettivo comune di descrivere e costruire un orizzonte diverso, votato ad una crescita equilibrata, stabile e non distruttiva dell’ecosistema ecologico, produttrice di coesione e giustizia sociale.
Questa alleanza deve muoversi su tre direttrici complementari e inscindibili
Stringere il tessuto dell’intervento socialesignifica reagire con determinazione, con competenze e con investimenti alle situazioni più complesse di questo tempo di transizione: marginalità gravi e affaticamento dei singoli e nelle relazioni sociali. Servono presìdi di prossimità per intercettare le fatiche e i bisogni, tessere reti di sostegno e mutualismo piuttosto che sperare che interventi securitari – sempre più ottusi e violenti – allontanino magicamente le problematiche dallo spazio pubblico e dalla vista.
Rimettere al centro dell’intervento pubblico le dimensioni essenziali a ogni livello – europeo, nazionale e locale – è una priorità non rimandabile. Lavoro dignitoso e salari adeguati; diritto all’abitare inteso come possibilità di sentirsi coinvolti in una comunità; accessibilità universale alla cura e alla sanità; formazione e crescita culturale per tutti lungo l’intero arco della vita. Questi non sono costi su cui tentare di risparmiare, ma investimenti strategici lungimiranti e generativi come nessun altro.
Pianificare modelli economici innovativi e sostenibili è l’unico modo che abbiamo per superare la dipendenza eccessiva dalle filiere turistiche o dal terziario non avanzato, per stimolare forme di imprenditoria ambiziosa capace di coinvolgere lavoratori e lavoratrici in sfide votate al futuro. Parliamo di transizione ecologica, di innovazione tecnologica, di economia circolare, di nuovi modelli produttivi che sappiano coniugare competitività e inclusione sociale frutto di politiche industriali coraggiose, investimenti pubblici mirati, accompagnamento all’Università e alla ricerca.
L’alternativa va costruita ora
Non esiste un tempo diverso da questo cui rimandare decisioni cruciali come quelle qui sopra abbozzate. Rosa Luxemburg aveva visto giusto. O si costruisce una società fondata su giustizia e solidarietà, oppure si scivola nella barbarie dell’indifferenza, della precarietà sistemica, della guerra di tutti contro tutti.
Chi si assume la responsabilità della costruzione di questa alternativa?Chi è disposto a mettere da parte interessi di piccolo cabotaggio per dar vita alla grande alleanza sociale di cui abbiamo bisogno?
La povertà non è un destino inevitabile, ma il risultato di scelte politiche e economiche precise. Come tale, può e deve essere combattuta, ma solo se smettiamo di considerarla un problema di altri e iniziamo a riconoscerla per quello che è: la questione centrale del nostro tempo, quella da cui dipende il futuro stesso della democrazia e della convivenza civile.
0 commenti all'articolo - torna indietro
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Collettivo di scrittura
- Consiglio provinciale 2008-2013
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Il monito della ninfea
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Sicurezza
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi