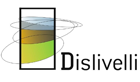«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»
Manifesto di Ventotene
Conservare abitando. Per una nuova geografia delle terre alte.

di Federico Zappini
(20 settembre 2025) La fine dell’estate – con lo zero termico per giorni oltre i 5000 metri – è il momento giusto per una riflessione sul nostro rapporto con ambiente e territori montani. Per farlo però partirò dalla laguna veneziana e da una città d’arte, Roma.
Venezia. L’isola di Poveglia era stata messa in vendita dall’Agenzia del Demanio, con il rischio concreto di trasformarsi in resort di lusso. Solo la mobilitazione civica – con i comitati ad ottenerla in concessione, dopo dieci anni abbondanti di battaglia – l’ha sottratta alla speculazione, salvandone la sua identità naturalistica e culturale. Si apre ora una nuova fase di protezione attiva degli ecosistemi e valorizzazione responsabile degli spazi che saranno recuperati grazie a energie e competenze dei cittadin* attiv*.
Roma. Anche le superfici della Cappella Sistina subiscono gli effetti dell’overturism. L’elevato numero di visitatori compromette la conservazione degli affreschi, richiedendo interventi di restauro sempre più frequenti. La fruizione di massa di beni naturali o artistici mette a rischio ciò che ci siamo dati il compito di tramandare integro alle generazioni future.
Dolomiti. I crolli di questi anni – la Marmolada prima, la cima Falkner nel gruppo di Brenta poi – testimoniano la fragilità di quello che rappresenta un hotspot climatico, stressato da condizioni ecologiche e ambientali mutate radicalmente. Le Dolomiti patrimonio Unesco vedono ogni loro elemento a forte rischio: ghiacciai in ritirata e conseguente diminuzione delle acque a valle, foreste affaticate oppure che invadono disordinatamente prati aperti, qualità dell’aria che peggiora insieme all’aumento delle temperature, rocce e terreni instabili che amplificano il rischio di dissesto idrogeologico.
Ci troviamo di fronte a una nuova geografia “in movimento” che richiede un diverso approccio alla conservazione ambientale e un modo più consapevole di abitare il paesaggio alpino. Non più solo interventi puntuali a difesa di un particolare habitat, ma strategie integrate che ampliano gli ambiti di protezione finanche oltre l’invito di Edward Wilson di mettere a riserva “metà della Terra”. È auspicabile quindi che si stringano le maglie di una rete interconnessa di parchi ed aree protette dotandola di obiettivi, risorse e competenze per una gestione comunitaria a forte guida pubblica e coinvolgimento diffuso della cittadinanza, attingendo alle migliori tradizioni cooperative e legate ai domini collettivi. Dopo decenni di deriva privatistica è arrivata l’ora di rimettere al centro l’esperienza dei commons (i beni comuni) e dei commoner (le comunità).
La conservazione di cui abbiamo bisogno non ci riporta alla separazione netta tra uomo e natura ma si propone di ri-abitare e ri-lavorare nelle terre alte e nella montagna di mezzo. Un patto sociale e ambientale che Aldo Bonomi associa al rafforzamento di geocomunità di pratiche nella prossimità, pronte a mettersi in mezzo alla “globalizzazione spaccata” che sembra crollarci addosso. Nella stessa direzione si muove l’appello rivolto al Governo da un gruppo di vescovi che proprio delle aree interne si occupano. La professoressa Elena Granata coglie le potenzialità di questo “viaggio in Italia alla rovescia” che riscopra i territori marginali come laboratori di futuro, avamposto di un modello alternativo più rispettoso dei limiti naturali e dei ritmi comunitari. Perché anche dove la montagna a trazione turistica ha evitato lo spopolamento lo ha fatto incorporando uno dei peggiori vizi dell’ambiente urbano: la velocità. Una fruizione accelerata svilisce il senso della vita (temporanea o permanente) in quota e – non secondario – moltiplica gli infortuni, mai così numerosi come negli ultimi mesi.
La montagna ha bisogno di lentezza, intesa come elemento fondante del saper prendersi cura e del prestare vera attenzione. Non è casuale che il camminare (sportivo, ambientale, culturale o spirituale) sia tornato a essere riconosciuto come pratica ecologica più capace di ristabilire un equilibrio tra corpo, tempo, territorio. Riconoscendo questa dinamica va colta la possibilità di valorizzare reti di cammini e sentieristica, interconnettendo i percorsi esistenti per creare itinerari per turismo di prossimità più consapevole, attraverso soggiorni prolungati che permettano di sviluppare relazioni autentiche con territorio e comunità, superando la logica del consumo quantitativo e istantaneo di paesaggio e diventando essi stessi protagonisti della conservazione ambientale.
Anche i ritmi quotidiani delle nostre esistenze cittadine dovrebbero essere contagiati da questo approccio. Alle città che rallentano le velocità di percorrenza (con l’allargarsi delle “zone 30 km/h”) deve corrispondere anche una modifica dei tempi di vita, puntando a settimane lavorative da non più di 30 ore, a parità di retribuzione. In questa prospettiva anche le attività didattiche estive – il prolungamento nel mese di luglio, di cui tanto si è discusso – diventano un’opportunità per sperimentare settimane multidisciplinari in quota dove l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza diretta nell’ambiente montano.
Il Monte Bondone (di cui nell’ultimo periodo si discute quasi esclusivamente in termini infrastrutturali) può in questo senso diventare spazio di sperimentazione, in prospettiva come Parco Naturale locale in stretta sinergia con la città che via via si ri-naturalizza, dentro un sistema metromontano che ridefinisce i confini tra urbano ed extra-urbano, rendendoli porosi e necessariamente collaborativi. Centro di ricerca, formazione e divulgazione per le trasformazioni ecologiche dell’arco alpino. Quartiere diffuso in quota, a valle di una nuova pianificazione condivisa del territorio. Ecosistema economico – su tre versanti, verso altrettante comunità di valle – che reinterpreta le proprie vocazioni e ristruttura le sue filiere produttive
Conservare oggi significa riabitare con consapevolezza le terre alte, trasformando ogni gesto quotidiano in un atto di cura. Il geografo Giuseppe Dematteis ci invita alla pratica dell’immaginazione geografica come capacità di “di cogliere nel disordine della Terra certi segni e dare ad essi un senso”, così come dovrebbe saper fare una terra di autogoverno come la nostra. Proviamoci.
* da https://pontidivista.wordpress.com
0 commenti all'articolo - torna indietro
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Collettivo di scrittura
- Consiglio provinciale 2008-2013
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Il monito della ninfea
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Sicurezza
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi