«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani»<br/> Manifesto di Ventotene
- Affari & Politica
- Agricoltura e alimentazione
- Alto Garda e Ledro
- Ambiente e biodiversità
- Balcani
- Biblioteca
- Cittadinanza Euromediterranea
- Coalizione
- Collettivo di scrittura
- Consiglio provinciale 2008-2013
- Cultura
- Darsi il tempo
- Democrazia e partecipazione
- Disegni di legge
- Economia
- Editoriali
- Europa e Mediterraneo
- Fiemme e Fassa
- Formazione
- Giudicarie e Rendena
- Gruppo PD del Trentino
- Il monito della ninfea
- Inchiesta sulla pace
- Interrogazioni
- Interventi
- Inverno liquido
- Lavoro e politiche sociali
- Lettere
- Libri
- Migrazioni
- Mondo
- Nel Limite
- Ordini del giorno
- Pace e diritti umani
- Palestina
- Partito Democratico
- Persone
- Primiero e Vanoi
- Regione
- Regioni
- Regioni europee
- Ricerca politica
- Rotaliana e Val di Cembra
- Scuola ed educazione permanente
- Sicurezza
- Slow Food
- Storia
- Südtirol - Alto Adige
- territoriali#europei
- Territorio trentino
- Trento
- Turismo responsabile
- Vallagarina
- Valle dei Laghi
- Valli di Non e di Sole
- Valsugana
- Viaggi
Lettere
Nei giorni scorsi è stato lanciato un appello al Sindaco di Roma per riconsiderare simboli e toponomastica del colonialismo italiano che segnano innumerevoli luoghi pubblici di Roma. Un analogo appello è stato rivolto al Presidente della Regione Lazio. L'iniziativa prende il via dopo la pubblicazione del libro "Roma coloniale" di Silvano Falocco e Carlo Boumis (Edizioni Le Commari, 2022) e ha suscitato un dibattito pubblico tutt'altro che banale. Sappiamo bene come i simboli rappresentino molto spesso ferite aperte che andrebbero innanzitutto riconosciute, elaborate, storicizzate, sanate. Pensiamo a come il tema della toponomastica rappresenti una questione aperta e divisiva nel vicino Sid Tirolo - Alto Adige, una terra oggetto di occupazione coloniale da parte dello Stato italiano e del suo tragico ventennio fascista. In realtà in ogni città e comune abbiamo a che fare con i segni del fascismo o delle conquiste della follia imperiale: monumenti, edifici, strade e piazze che ricordano questo passato inglorioso o personaggi che, a scavare poi nemmeno molto, erano figure ignobili o generali che hanno massacrato e mandato al massacro tanta povera gente. Senza dimenticare che tutto questo coinvolge anche storie famigliari che spesso preferiamo rimuovere. Non si propone di cancellare questo passato, ma di considerarlo per quello che è stato, affinché diventi occasione per un percorso di rivisitazione critica della storia. Roma si è proposta di farlo a partire da un libro che a riaperto pagine spesso dimenticate e altrimenti destinate all'oblio. Personalmente parlo spesso della necessità di elaborare il Novecento. Pensiamoci, ma ci sarebbe lavoro per tutti. Anche nelle nostre prossimità. L'Appello che qui viene riportato, insomma, ci riguarda. Potremmo iniziare con il firmarlo, aderendovi, aggiungendo un vostro commento, scrivendo sulla mia pagina di facebook. (m.n.)
Lettera appello al Sindaco d Roma Roberto Gualtieri – Roma capitale
***
La nostra città, ancora oggi, custodisce centinaia di tracce del feroce colonialismo italiano, celebrato attraverso piazze, vie, viali, larghi, ponti, lapidi, busti e palazzi la cui presenza muta permette di continuare a godere del senso di superiorità imperiale di cui sono intrisi.
Una vera e propria odonomastica coloniale che fa di Roma, con oltre 140 odonimi, il luogo d’Italia maggiormente connotato da quell’esperienza storica.
Come Lei ben sa, anche per il contributo essenziale delle seconde generazioni, è sorto ovunque, nel nostro paese, un movimento di “de-colonizzazione dello sguardo” che, nelle città, chiede di assegnare un significato nuovo, veritiero e più giusto, a quelle tracce, perché oggi é impossibile continuare a vedere statue, monumenti o vie intrise di storia coloniale in modo innocente, acritico.
Un primo intervento ha portato il Consiglio Comunale di Roma Capitale, il 4 agosto 2020, ad approvare una mozione per intitolare la fermata della metro C non all’Amba Aradam - luogo di una battaglia feroce che vide l’uccisione di migliaia di etiopi per mano dell'esercito e dell'aviazione italiana con l’uso di gas tossici – ma a Giorgio Marincola, partigiano nato in Somalia, legato al Partito d'Azione e ucciso in Val di Fiemme nel maggio del 1945.
di Giuliano Muzio
(Luglio 2022) La Festa dell’Unità di Nomi è ormai diventata una tradizione consolidata per il Trentino. Giunta alla sua 73° edizione, da tempo non si cura del fatto che il giornale da cui ha preso il nome non esista più, ma, grazie agli sforzi di una comunità che trova proprio nella festa un suo momento di coesione e rinnovamento, ha proseguito le sue attività con l’intento di offrire momenti di svago e di socialità, nel solco delle tradizioni ideali che l’hanno generata.
Quest’anno si trattava di riprendere dopo la forzata sosta pandemica e, purtroppo, di registrare il triste ritorno della guerra in Europa. Per questo, nel consueto momento di socialità della domenica mattina, solitamente dedicato ai canti corali della Resistenza, stavolta si è voluto parlare di Europa e si è deciso di farlo con Michele Nardelli che da anni, in modo tanto autorevole quanto originale, affronta il tema partendo da una prospettiva storica e culturale. È stato un bel modo di confrontarsi, ripercorrendo i passaggi storici che ci hanno portato alla situazione attuale. Constatando che hanno radici profonde, quasi millenarie, spesso ignorate, più o meno volutamente.
***
Dopo circa quattro mesi dall’inizio della guerra in Ucraina proponiamo una serie di brevi riflessioni
che riteniamo utili sia di fronte alla congiuntura attuale che in una prospettiva futura.
1. Innanzitutto, per non ripetere gli errori del passato, va preso atto come questa guerra dimostri – se mai ce ne fosse bisogno – che la pace si costruisce, prima di tutto, coltivandola quotidianamente e costantemente. Nessuna guerra ha un inizio improvviso ed imprevisto. Di conseguenza stupisce che alcune istituzioni internazionali (l’ONU e l’Unione Europea in particolare) si siano rivelate incapaci di presidiare, monitorare e, dove necessario, intervenire (in termini diplomatici e di interposizione a tutela dei civili) ben prima che le fratture diventassero insanabili. Non possiamo sempre occuparci dell’oggi, ignorando cosa è successo ieri. Altrimenti domani saremo daccapo.
Caro Professore caro,
ti scrivo, ancora una volta.
Questa lettera veleggerà nell’aria fino a raggiungerti nel silenzio dell’universo dove sei approdato. Non posso ignorare il morso di dolore che stringe lo stomaco, al pensiero della morte nonostante la tua lunga complicata vita.
Di recente ho attraversato le dolenti spiagge dell’abbandono della persona amata ed ora il saluto che devo rivolgere a te acuisce il solco della perdita. Delle varie perdite, che si sommano a mano a mano che si devono salutare i volti di quanti hanno intercettato i nostri passi e con cui si sono condivisi pensieri e speranze.
Nel tuo romanzo “Il petalo giallo”1 hai messo in campo lo scambio di lettere tra i personaggi della storia narrata, ribadendo che le lettere collegano, spiegano, fanno affiorare il rimosso, illuminano, aiutano. Tra i protagonisti, Igor a Magda, un tempo le lettere erano state “un dono, di una creatura accorta ma sognatrice e infantile, che l’aveva aiutato a ritornare nel mondo degli esseri umani”, perché l’invio di missive in qualche caso permette di ricucire gli strappi della vita.
Forse anche fra noi, pur in piccola misura, i messaggi scambiati hanno lenito momenti di solitudine. Leggendo le tue narrazioni, ho intercettato tante domande ed è forse da qui che ha preso il via la nostra corrispondenza, fatta di cartoline e di lettere, scritte a mano o battute a macchina, come facevi solitamente, secondo antica usanza. Per questo oggi ti scrivo e, col tuo permesso, condivido pubblicamente alcuni argomenti di cui abbiamo discusso da lontano.
Spero che altri possano raccogliere il testimone e proseguire allargando il cerchio del dialogo intrapreso.
Un abbraccio denso di affetto.
Micaela
di Giulio Costa *
Azzurro è il colore del vuoto. Esordisce così, durante una seduta di psicoterapia, una mia paziente riferendosi al proprio lutto e al proprio vuoto personale per la recente perdita di un familiare: un dolore che ha visto rispecchiarsi nella voragine di ghiaccio azzurro lasciata dal drammatico distacco del seracco della Marmolada.
Al pari della siccità che da mesi sta colpendo il nostro territorio, la tragedia della Marmolada è diventata nuovo simbolo dell’evidente cambiamento climatico.
Tuttavia, lo sguardo diverso della mia paziente alle fotografie che da giorni riempiono quotidiani, telegiornali e social, mi hanno rivelato come quella voragine rappresenti il nostro umano e contemporaneo rapporto con il limite e la fragilità.
Un baratro fisico, naturale, ma al contempo psichico e sociale. A partire dal Secondo Dopoguerra, abbiamo via via soffocato ogni discorso sulla fragilità, sul dolore e sul senso del limite.
#MahsaAmini
Viaggio con l'autobus. Ho bisogno della sua lentezza, ferma in tanti luoghi, alcuni scendono, altri salgono, ma l’autobus - questa presenza costante, rossa e gigante - rimane la stessa e scorre in città, una presenza stabile, umile e rossa. Salgo le scale e mi siedo di fronte ad una finestra immensa che si apre verso la città: sono in prima fila e vedo come scorre con il suo ritmo quotidiano, indifferente, ma che indifferente non è, cambia costantemente e la mia mente continua a sentire la canzone di Shervin:
Per…
Per ballare per strada
Per avere paura quando baci l’amato
Per mia sorella
Tua sorella,
Le nostre sorelle
C’è una «fraternità del dolore» di cui dovremmo fare tesoro: la sentiamo come un codice genetico, come una pulsazione naturale, dentro i nostri cuori.
di Nichi Vendola *
Kiev siamo noi. Ogni singolo fotogramma catturato sui fronti di guerra ferisce il nostro sguardo e il nostro sentimento di umanità. Ogni dolente cronaca della devastazione comandata da Putin ci spinge dentro la voragine di un regresso da cui pensavamo di essere risaliti faticosamente. Kiev, Mariupol, Odessa, Kharkiv siamo noi. Le città squartate, incenerite e fumanti del martirio ucraino sono lo specchio rovesciato delle nostre città vibranti di incontri, di suoni, di socialità. Siamo anche noi le famiglie strappate al tepore domestico, alla serenità degli affetti, alla normalità della vita quotidiana. E noi siamo loro: la stessa razza umana, lo stesso diritto alla dignità, la stessa ambizione di camminare eretti guardando il cielo, le stesse lacrime quando si strappa la trama preziosa della vita.
Voglio dire che c’è una «fraternità del dolore» di cui dovremmo fare tesoro: la sentiamo come un codice genetico, come una pulsazione naturale, dentro i nostri cuori, dentro le nostre pupille che non smettono di guardare. Eccola l’umanità oltraggiata, eccola nella sua corsa al cardiopalma per sfuggire alla mattanza, per mettere in salvo un bimbo, ma anche un gatto o un cane, per stringersi nel rifugio mentre il proprio quartiere rimbomba per le detonazioni, per non lasciarsi seppellire dalle macerie della propria casa che crolla, eccola separarsi dai propri affetti e dai propri luoghi, salutare il proprio universo e salpare verso destinazione ignota: non c’è intelligenza geopolitica che non debba misurarsi innanzitutto con questa sofferenza, con l’orrore dell’aggressione criminale di un autocrate imbalsamato sul suo trono. Non si può separare il discernimento dalla compassione. E in queste settimane di sgomento forse abbiamo persino imparato a comprendere il significato amaro e tristissimo della parola profugo: chi fugge dalla città che brucia, proprio come Enea, non è un turista o uno speculatore imboscato...





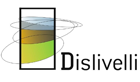





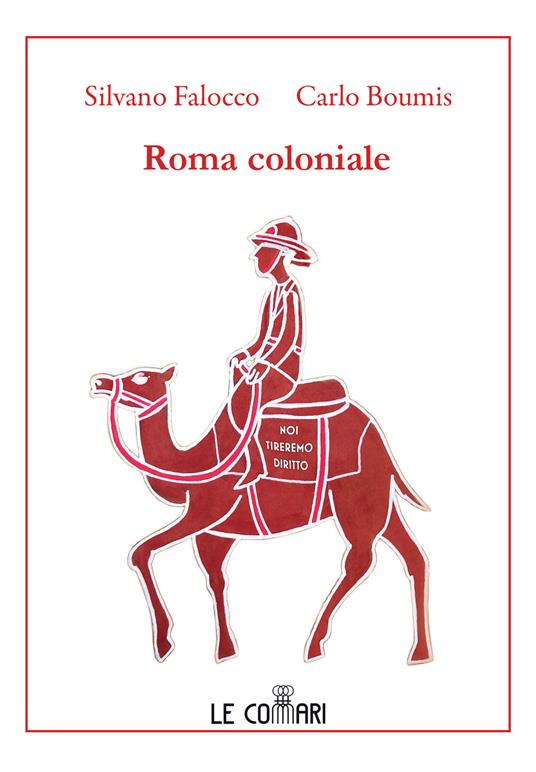
.jpg)
.jpg)



(1).jpg)